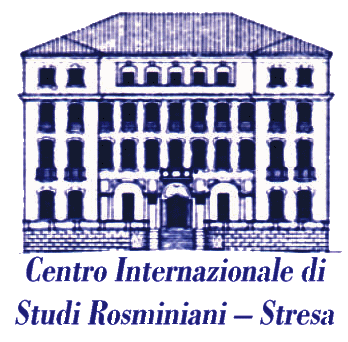Ci siamo soffermati un po’ a lungo sul ritiro di Rovereto, perché tutto quello che Rosmini intraprenderà poi, si spiega alla luce del principio di «passività» che egli stabilisce proprio in quegli anni, nel raccoglimento e nella preghiera davanti a Dio. Anche nello stabilire e seguire quel «principio» egli mette Dio prima di tutto, la sua volontà, il suo «beneplacito», come egli ama dire.
La sua vita si svolgerà in seguito in due direzioni: nel governo dell’istituto religioso che fonderà dì lì a qualche anno, e nell’opera di pensatore e di scrittore per la restaurazione della filosofia: nel campo, cioè, del sapere, che per lui sarà esercizio di «carità intellettuale» . Ma all’una e all’altra di queste due direzioni della vita, non giungerà di propria scelta; vi sarà condotto dalla volontà di Dio.
Un primo invito a dar forma ad un istituto religioso, gli viene nel 1821 da Maddalena di Canossa, fondatrice delle Figlie della Carità. Essa – per la stima e venerazione che ha di lui – lo esorta a dare vita alla Congregazione religiosa dei Figli della Carità, da affiancare a quella da lei fondata. Rosmini accoglie l’invito ma soltanto per «meditarvi» su, non bastandogli, per passare all’esecuzione, quella richiesta, sia pure di una donna santa come la Canossa.
Mantiene con lei corrispondenza epistolare per qualche anno, sempre su questo argomento; ma sente che il Signore non lo chiama ancora a quell’opera.
Soltanto nell’estate del 1827, a Milano, ove si era trasferito nel 1826 per avere un ambiente più vasto per i suoi studi, si danno circostanze che l’inducono a convincersi che era giunto il momento di dare inizio a quell’opera, il cui progetto egli aveva per anni coltivato nella mente e nel cuore.
L’inizio dell’istituto religioso si ha sul Monte Calvario di Domodossola, nel febbraio 1828: anche questo luogo non era scelto da Rosmini, ma indicatogli da amici (l’abate Luigi Polidori, cappellano del conte Giacomo Mellerio). L’inizio è veramente singolare: al Calvario, Rosmini è solo: prepara le Costituzioni del nascente istituto e attende che la Provvidenza gli mandi poi i compagni. Che verranno man mano, nel tempo.
Rosmini denomina la nuova società religiosa Istituto della Carità. E mette ad essa il medesimo fondamento che egli aveva posto alla base della propria condotta: e cioè, l’Istituto deve professare la carità «universale», ossia la carità spirituale, la carità intellettuale e la carità corporale, per il bene del prossimo. Ma non deve essere l’Istituto – cioè i responsabili del medesimo – a scegliere le opere di carità da esercitare: esso deve intraprendere le opere che gli vengono richieste, purché abbia religiosi idonei e disponibili.
Se poi non è richiesto di alcun’opera di carità, l’Istituto consegue lo stesso il suo fine che è quello della salvezza e perfezione delle anime dei suoi membri. Per l’esercizio, così, della carità «Universale», si richiede che i religiosi dell’Istituto siano «disponibili» a qualunque opera venga loro affidata. Naturalmente sarà compito dei superiori di mettere il religioso giusto nell’opera giusta. Rosmini stenderà i regolamenti per tre Collegi deputati alla formazione dei religiosi in questi diversi rami della carità: il Collegio dei missionari, per la carità spirituale; il Collegio degli educatori elementari, per la carità intellettuale, e il Collegio medico, per la formazione dei medici e la cura degli ammalati (le circostanze permetteranno che avesse vita sollanto il Collegio degli educatori elementari).
Bisogna rilevare che l’apertura alla «carità universale», caratteristica dell’Istituto, risponde a tutto lo spirito di Rosmini, sia nel campo ascetico, sia in quello del pensiero. Anche il «pensare» di Rosmini è universale, abbraccia cioè «tutto l’essere», l’essere in tutte le sue forme, e cioè la forma ideale, la forma reale e la forma morale.
L’essere è «bene», e lo è in tutte le sue forme. La vera carità, quindi, deve volere e procurare al prossimo tutto il bene, e cioè il bene nella sua forma ideale, ed è l’istruzione, la formazione della mente; il bene nella sua forma reale, ed è tutto ciò che giova al corpo; il bene nella sua forma morale, ed è tutto ciò che serve alla vita spirituale dell’anima. In tutte queste dimensioni va la carità professata dall’Istituto rosminiano.
Alla fine del 1828, Rosmini va a Roma per sottoporre al Santo Padre il progetto dell’Istituto e per avere da lui conferma della volontà di Dio. E Pio VIII, nel maggio 1829, approva il progetto e incoraggia Rosmini a darvi esecuzione: poi gli dice: «È volontà di Dio che Ella si occupi nello scrivere libri: tale è la sua vocazione. La Chiesa al presente ha gran bisogno di scrittori; dico di scrittori solidi, di cui abbiamo somma scarsezza. Per influire utilmente sugli uomini, non rimane oggidì altro mezzo che quello di prenderli colla ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione. Si tenga certo, che Ella potrà recare un vantaggio assai maggiore al prossimo occupandosi nello scrivere, che non esercitando qualunque altra opera del sacro ministero».
Il Santo Padre conosceva qualche scritto di Rosmini: erano già stati pubblicati, infatti, alcuni suoi saggi, come il libro Dell’educazione cristiana (in cui il Manzoni disse di sentire lo «spirito dei Padri della Chiesa»), un saggio sulla Divina Provvidenza e un altro Sull’unità dell’educazione, e i due volumi degli Opuscoli filosofici. Scritti minori, si deve dire, ma in cui già si sentiva il pensatore geniale e di grande ricchezza intellettuale.
E così, dopo le autorevoli parole del Papa, l’opera di pensatore e di scrittore diviene per Rosmini un modo di corrispondere con sicurezza alla volontà di Dio. Egli ne rimane profondamente convinto: e lo scrive esultante agli amici: «In tal maniera quel sommo Pontefice di santa memoria mi tracciava la via, e m’esortava a calcarla: e non posso dimenticarmi con quali parole e con quanto calore e bontà seguitasse a dimostrarmi la verità del suo consiglio, e specialmente a persuadermi, che gli uomini dovevano condursi col ragionamento. Così fu determinata la direzione dei miei studi successivi, e la riforma della filosofia divenne l’intento universale dei lavori fin qui da me pubblicati o promessi; a cui consegue di sua natura quella restaurazione di tulle le altre scienze, delle quali la filosofia è madre e nutrice, principalmente delle morali, dove ogni decoro ed ogni onore dell’umanità consiste» (Discorso sugli studi dell’autore).
A Roma, per significare che tutto sottometteva all’autorità della Santa Sede e tutto dedicava al bene della Chiesa, pubblica nel 1830 la sua prima grande opera filosofica, il Nuovo saggio sull’origine delle idee e il libretto – grande però di contenuto – delle Massime di perfezione cristiana in cui vi è in compendio tutta la sua dottrina ascetica.
L’Istituto della Carità si arricchisce man mano di religiosi che Rosmini segue personalmente, di presenza e con la corrispondenza epistolare, per aiutarli, sostenerli e formarli al vero spirito del medesimo. Egli è rigorosissimo in quest’opera di formazione, pure con la finezza, la discrezione e il discernimento spirituale, che lo porta a comprendere e ad immedesimarsi in ciascuno dei suoi religiosi.
Nel 1832, dà pure inizio alla Congregazione delle Suore della Provvidenza, impostata sulle stesse basi ascetiche proprie dell’Istituto della Carità. E giungono le prime richieste per opere di carità, prevalentemente per scuole. Inizia così l’opera dei «maestri» e delle «maestre» rosminiane, che perdura tuttora.
Una parentesi, purtroppo non lieta, si ha, in quei primi anni dell’Istituto, con l’apertura di una casa in Trento e con la cura della parrocchia di San Marco in Roverero, a cui viene chiamato Rosmini stesso nel 1834. Entrambe le opere si interromperanno nel 1835, impedite da circostanze ostili. L’Austria non agevolò mai le iniziative di Rosmini, non fidandosi di lui, suo suddito ma con sentimenti troppo grandi e ardenti per l’Italia. E fu una delle croci che la Provvidenza gli permise.
In compenso, si apre proprio allora una nuova porta all’Istituto, con la richiesta di suoi religiosi per missioni in Inghilterra. «I cattolici inglesi – scrive allora Rosmini – mi stanno tanto a cuore che non so che cosa farei, se fossi capace di giovar loro in qualche minima cosa; e penso da parte mia di non trascurare minimamente ciò che la divina Provvidenza mi presentasse da far in loro vantaggio, e vorrei dar loro anche il mio sangue per la gloria di nostro Signore, sebbene il mio sangue non val nulla».
I religiosi rosminiani scrissero una bella pagina nella storia del cattolicesimo inglese, cooperando alla restaurazione della gerarchia dall’Inghilterra, ancora vivente Rosmini, passarono poi anche in Irlanda. Nel mondo anglosassone lo spirito dell’Istituto – di sua natura «universale» – permise ai religiosi di adattarsi sapientemente. Più tardi, nei primi decenni di questo secolo, dall’Irlanda i religiosi rosminiani passarono anche negli Stati Uniti d’America, e dall’Inghilterra alla Nuova Zelanda. Oggi sono anche in Venezuela, Tanzania ed India. Così pure le Suore rosminiane.
L’Epistolario di Rosmini ci dà la misura della sua grandezza d’animo, della sua apertura a tutto il bene, della sua sapienza e prudenza e zelo e discrezione nell’intraprendere le varie opere che venivano richieste, nel seguirle dopo averle assunte, nel mettere in primo piano il bene delle persone e non quello dell’opera, nell’indirizzare tutto alla vera gloria di Dio. Le migliaia di lettere che egli scrive, sono il tracciato più efficace della sua vita.
Nel 1838, l’Istituto della Carità viene approvato dal papa Gregorio XVI. Nelle Lettere apostoliche di approvazione, il Papa designa di sua autorità Rosmini come superiore generale dell’Istituto, derogando per quella volta dalle norme delle Costituzioni per l’elezione del superiore generale. E lo fa, perché gli consta «che il diletto figlio Sacerdote Antonio Rosmini è persona fornita di elevato ed eminente ingegno, adorna di egregie qualità d’animo, per la scienza delle cose divine ed umane sommamente illustre, chiaro per la sua esimia pietà, religione, virtù, probità, prudenza e integrità, e splendente di meraviglioso amore e attaccamento alla cattolica religione e all’Apostolica Sede». Queste parole, per suggerimento del Manzoni, saranno incise sulla tomba di Rosmini a Stresa.
Mentre si occupa della vita dell’Istituto e delle opere che esso viene man mano assumendo e si cura amorosamente del bene dei religiosi, attende anche all’altra grande opera che dal Papa gli era stata indicata come sua particolare «vocazione»: lo «scrivere libri. Fu questa, come si sa, la sua gloria e la sua croce.